Crisi economica e crisi dello stato sociale
La specificità della crisi attuale
Da qualche mese ci stiamo interrogando sugli effetti della crisi innescata dalla pandemia da Coronavirus e sulle possibili vie d’uscita dall’impasse in cui sembra caduto il mondo intero.
Le attività economiche sono “sospese”, le frontiere chiuse, i comportamenti delle persone sono cambiati (non si capisce se in modo permanente oppure no). Fatto sta che, salvo alcuni paesi (come il Brasile, gli USA e in parte la Gran Bretagna), la maggior parte delle nazioni ha dato priorità al salvataggio di vite umane, attraverso la tecnica del distanziamento sociale e del lockdown delle attività. Attenzione! Non tanto e non solo i governi nazionali, ma soprattutto i cittadini consumatori, che tengono alla propria salute personale più che alla salute del proprio business (Walter Scheidel – Foreign Affairs / Maggio 2020).
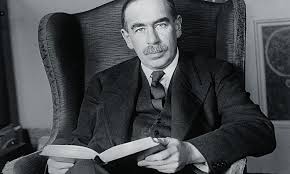
Questa scelta comporta necessariamente una riduzione dei consumi e un rallentamento delle attività produttive. Se almeno la metà della popolazione mondiale rimane chiusa in casa, riduce la spesa e ferma i progetti di investimento, in attesa di un vaccino che non arriva, la domanda resta depressa, nonostante gli incentivi delle autorità nazionali e inter-nazionali, che insistono a muoversi nel solco delle politiche “monetariste” (o pseudo-keynesiane aggiornate). E se anche la metà della popolazione continua a lavorare o cerca di riprendere i livelli di vita e di consumo ante-Coronavirus, i limiti al movimento delle merci e delle persone (che si aggiungono a quelli indotti dalle politiche protezioniste di USA e Cina), frenano la ripresa della domanda aggregata a livello globale.
Due importanti leve di crescita economica (il turismo e gli scambi internazionali), che hanno alimentato il PIL globale negli ultimi decenni, sono spezzate e mettono sul lastrico paesi come l’Italia (ma anche la Germania), che da quelle leve dipendono in maggiore misura. Anche se gli USA e la Cina riuscissero a rilanciare il mercato interno, mantenendo il regime dei vincoli protezionistici, difficilmente farebbero da traino per economie “export led” come quelle europee.
La crisi attuale non ha dunque eguali nella storia del mondo moderno, poiché tutte le vie d’uscita sono bloccate, contemporaneamente, in tutti i paesi del mondo e la via della ripresa “as usual” sembra interdetta.
Neanche la crisi del ’29 ha avuto una portata e una diffusione come quella attuale. E’ durata molti anni ed è stata superata grazie a due cambiamenti importanti nell’assetto istituzionale, nel ruolo dei soggetti sociali e degli agenti collettivi:
- in primo luogo la maggioranza delle nazioni è passata dalle istituzioni tipiche dello “stato liberale” (poco interventista, leggero, e finalizzato a sostenere la leadership economica dei grandi capitalisti privati) alle istituzioni dello “stato sociale” (molto più impegnate nella gestione pubblica dell’economia e degli investimenti, orientate a compensare i lavoratori dei rischi inevitabili dell’iniziativa privata, attraverso un nuovo meccanismo “estrattivo” – il welfare pubblico);
- in secondo luogo si è passati dallo stile di vita e di consumo delle famiglie contadine e delle comunità rurali, alle consuetudini della vita urbana della cosiddetta società dei consumi, fatta di micro-investimenti su beni personali privati, come l’automobile, la radio, la casa di città e le vacanze al mare (turismo di massa).
Tra il 1930 e il 1950 (durante la transizione – traversata del deserto – durata più di vent’anni) la società si è trasformata: da una società organizzata per “eserciti”, nei quali il grado di libertà degli individui è oggettivamente contenuto (si pensi ai molti paesi, Italia inclusa, in cui le donne non potevano votare), a una società industriale aperta (american style), nella quale i margini di mobilità sono improvvisamente ampliati.
Lo stato sociale si è imposto, culturalmente e politicamente, prima nell’élite e nelle classi dirigenti (come alternativa allo “stato liberale” incapace di gestire le ricorrenti crisi di mercato) e poi nelle classi subalterne (che hanno rinunciato alle posizioni rivoluzionarie più estreme, in cambio di una maggiore stabilità di reddito e sicurezza sociale, anche e soprattutto grazie al sindacato).
La tesi che vogliamo sostenere è che la “società del welfare” ha avuto successo, perché ha coniato un sistema istituzionale (quello delle repubbliche democratiche, più o meno autoritarie o rappresentative) in grado di “estrarre valore” dal lavoro in modo più efficace del capitalismo delle origini ed è riuscita, almeno fino al 1989, a destinare il surplus (attraverso i ben noti meccanismo re-distributivi del welfare) a obiettivi desiderabili dai cittadini-consumatori (elettori dotati di entitlements –Dahrendorf), tramite organizzazioni burocratiche e tecnocratiche (più o meno efficienti) legittimate dal sistema dei partiti. La crisi attuale è il risultato delle decisioni assunte dal sistema istituzionale prevalente (soprattutto in Occidente) e non dalla restaurazione dei mercati neo-liberali senza controllo (o meglio controllati da un capitalismo privato extra-nazionale, che detta le regole nella terra di nessuno dell’economia globale), come sostiene la vulgata No Global e degli oppositori al cosiddetto Consenso di Washington.
Se così fosse è difficile pensare che la crisi attuale, che si avvia a diventare un’altra profonda depressione (una super-depressione secondo Lucio Caracciolo), possa essere risolta rapidamente, attraverso il ritorno di politiche “keynesiane convenzionali” o il rilancio di un mercato globale “as usual” (quello abbiamo conosciuto negli anni della metropolizzazione e dell’emersione dei BRIC) attraverso politiche neo-monetariste (tipo helicopter money).
Il Green New Deal Europeo (i 750 miliardi della Commissione, sostenuti da Francia e Germania) e anche un possibile Piano Straordinario per l’Africa (ultimo territorio di conquista della società dei consumi “as usual”), hanno l’ambizione di generare un processo di distruzione creatrice analogo a quello del New Deal Rooseveltiano delle origini. Tuttavia essi inciampano nelle trappole interne al sistema istituzionale “estrattivo” che ha guidato la crescita degli stati nazionali (burocratici) e delle imprese (pubbliche e private) fino al 1989. E anche nei limiti della cosiddetta economia globale “neo-liberale” (monetarista e mercantilista), attiva da tre decenni.
Tutti questi progetti di rilancio (quasi keynesiano) dell’economia mondo, non comportano cambiamenti sufficienti nell’identità dei soggetti sociali e degli agenti collettivi che sono stati protagonisti dello sviluppo post-bellico.
Lo “stato sociale” è oggi ridotto ai minimi termini, dopo la restaurazione dell’ideologia liberale del Consenso di Washington. Ha perso lo smalto e le competenze necessarie ad agire in modo “imprenditoriale” (come accaduto perfino in Italia, all’epoca dell’ENI, delle PPSS e delle grandi aziende IRI) e non sa più definire strategie di spesa e di investimento in deficit “desiderabili” per lo sviluppo delle componenti produttive della società. Anzi, a causa della gestione sempre più “estrattiva” della spesa pubblica (messa all’indice nell’accordo di Maastricht, ma non completamente sostituita dalle regole di privatizzazione e liberalizzazione dei mercati, dalla concorrenza, dal bail-in, dalla riduzione del potere contrattuale dei sindacati, ecc.), non è più in grado di realizzare neppure minimi obiettivi di “crescita”. Non è più fattore di sviluppo umano in senso generale.
Oggi non è chiaro quale sistema istituzionale (nazionale e inter-nazionale o sovra-nazionale) possa implementare una strategia di rilancio dello sviluppo (sostenibile, innovativo) e tradurre in politiche concrete gli auspici dell’Agenda 2030 e anche del New Deal comunitario.
I soggetti sociali occidentali si sono a loro volta trasformati. Anni di welfare state hanno prodotto ceti sociali “protetti”, dotati di entitlements, che hanno, nel tempo, ridotto la motivazione e l’impegno, l’etica meritocratica e la mobilità. Proprio questi ceti hanno immaginato e accettato la restaurazione neo-liberale, come strumento di “esclusione” dei ceti emergenti e degli immigrati (creativi, precari e freelance, para-schiavi) dal surplus in cronica insufficienza. Hanno prodotto, in alcuni paesi e, in particolare in Italia, una spaccatura della società, che non esisteva negli anni del boom economico.
Il welfare state italiano ha prodotto il sistema sociale “signorile” (o meglio “parassitario di massa”), quello di cui parla Luca Ricolfi, che è assai diverso e peggiore dell’affluent society di Galbright, induce migrazione dei cervelli, delusione/demotivazione imprenditoriale diffusa, tra i giovani del Nord e i ceti produttivi del Sud, ghetti inaccettabili e strumenti di sfruttamento legale dei migranti.
Difficile pensare che questo sistema sia in grado di mobilitarsi per pianificare una via d’uscita rapida dal pantano in cui è capitato, già prima del lockdown, e che è il risultato, appunto, della degenerazione del welfare state e della restaurazione di un mercato pseudo-liberista, che ha l’ambizione di risolvere la crisi dello stato keynesiano attraverso i conflitto sociale.
Se questo è vero per l’Italia, ma anche per molti altri paesi, è inevitabile prevedere non solo una crisi lunga e una fase depressiva che potrà durare anni, ma anche la progressiva emersione di una nuova visione del mondo e dell’economia, post-keynesiana e post-stato sociale estrattivo. I tempi del cambiamento, della transizione a un nuovo sistema, possiamo calcolarli in ragione della diminuzione della rendita oggi assicurata (secondo i calcoli di Ricolfi per l’Italia, ma anche secondo le osservazioni di Ralf Dahrendorf, per i paesi anglosassoni) ai due terzi della popolazione. Finché essa dura (finché ci sono risorse per pagare le pensioni, anche a debito) i beneficiari non sono motivati né al cambiamento della classe dirigente, né al controllo delle sue azioni. Solo quando la rendita viene meno, per forza di cosa scatta un meccanismo di auto-difesa che stimola la ricerca di una via d’uscita e di un gruppo dirigente in grado di assumere il comando delle operazioni.
Nuovi soggetti e agenti collettivi che possano impegnarsi per costruire una via d’uscita.
Oggi non è possibile prevedere quali saranno i soggetti sociali artefici dell’uscita dalla crisi, quale visione li contraddistingua e quali agenti collettivi essi siano in grado di costituire per trasformare le istituzioni del welfare state. Tuttavia, a partire dalla natura dei problemi che abbiamo davanti (in attesa di shock esterni in ciascuno dei 17 punti critici del sistema globale individuati dall’ONU), possiamo almeno tentare di ordinare le linee di frattura più evidenti, dentro le quali i designer del futuro saranno costretti a elaborare una strategia.
Una prima linea di frattura è la crisi di identità e motivazione dei soggetti sociali che sono protagonisti dello stato sociale (keynesiano).
I ceti protetti e privilegiati sono restii a mobilitarsi alla ricerca del cambiamento, anche se temono di perdere i benefici di cui godono attualmente. Nemmeno una crisi finanziaria e fiscale disastrosa come un default può promuovere la loro azione (vedi Grecia e Argentina). Eppure una componente “riformista” della società signorile di massa, che si muove con spirito elitario illuminato, proprio per anticipare il rischio di perdere vantaggi e potere (come Carlo Alberto nel 1948 italiano), può farsi avnati, ma difficilmente è in grado uscire dallo schema, dalla costituzione materiale di cui è artefice da troppo tempo.
I ceti esclusi, al contrario, non avendo entitlement e vantaggi di qualche tipo dal regime esistente, sono naturalmente più disponibili a investire su nuovi orizzonti. Non hanno nulla da perdere e, in molti casi (freelance e P.IVA), scelgono una condizione sociale incoerente con il sistema prevalente di welfare, vivono la contraddizione, rifiutano di riconoscersi nelle parole d’ordine e nelle forme di rappresentanza del sindacato confederale e dei partiti conservatori. Sono un soggetto ibrido, strutturalmente dalla parte del mercato e del rischio, ma culturalmente dalla parte della solidarietà sociale, quella vera, profonda. Il fatto è che, al momento, questi ceti sono una minoranza difficilmente “organizzabile”, perché non strutturata, come soggetto “collettivo”, non sono “coerenti” con le istituzioni dello stato sociale. Non hanno voce. Non hanno trovano strumenti espressione adeguati a valorizzare il proprio ruolo e il proprio status (voice), le proprie competenze, neppure attraverso il mercato, i social, le Sardine e i Vaffa Day. Sono condannati alla soluzione “exit”.
Questo genere di soggetti sociali è forse la maggioranza in Africa, continente nel quale le contraddizioni dello stato nazionale estrattivo raggiungono un apice (per le ragioni elencate da Acemoglu e Robinson nel loro libro “Why Nations Fail”). E non a caso proprio l’Africa è territorio di grandi migrazioni, così come il Medio Oriente islamista. Ma questo genere di soggetti è in forte crescita, proprio per le scelte dei leader e delle organizzazioni “proprietarie del welfare state”, anche in Europa e negli USA.
Nel mondo è come se affiorasse una spaccatura tra i ceti sociali “stanziali” (dotati di entitlements e destinatari del valore estratto dagli stati nazionali “sovranisti”) e ceti sociali “migranti” (esclusi dai sistemi di welfare e condizionati al conflitto o all’uscita dall’area del governo e della rappresentanza). Nel contesto globale di oggi, non è un caso che il conflitto principale sia tra “migranti” e “stanziali”, tra cervelli in fuga e soggetti sociali “protezionisti”, tra sovranisti trumpiani e alternativi anti-razzisti.
E questo conflitto è il risultato degli stati sociali nazionali (nazionalisti) e del regime estrattivo (proprio dello stato sociale keynesiano) che privilegia i “residenti” (i proprietari del territorio). Si tratta di un conflitto nuovo rispetto a quello individuato da Marx, nella contraddizione tra capitale e lavoro. E’ un conflitto che attraversa la democrazia nazionale rappresentativa, dominante in Occidente dopo il secondo conflitto mondiale. E’ un conflitto che attraversa il popolo, che contrappone ceti e cittadini “privilegiati” e ceti e cittadini “esclusi o migranti”, con una forza che non ha eguali nella storia moderna.
Dal punto di vista del cambiamento, è necessario che emerga una visione condivisa del problema e si sviluppi una saldatura tra diverse componenti (quella riformista interna ai ceti privilegiati e quella innovatrice radicale nei ceti esclusi), attorno un collante ideologico nuovo. Attorno a una nuova élite.
Un aspetto critico in questa situazione è il ruolo dei soggetti imprenditoriali “intermedi” (PMI e leader globali) che si sono sviluppati nel regime di mercato alimentato dal welfare state keynesiano e delle burocrazie nazionali (estrattive).
Sviluppatisi nella fase più recente della globalizzazione (Second Industrial Divide), grazie all’apertura dei mercati inter-nazionali, questi soggetti operano spesso fuori dal loro paese o su aree di domanda interna (servizi alle imprese, comunicazione, prossimità) di tipo nuovo, non regolato. I più piccoli sono esclusi nello stato sociale nazionale tradizionale o non fanno parte del “club” dorato degli imprenditori extra-nazionali di medie e grandi dimensioni. Finora sono stati organizzati dalle associazioni “nazionali”, che sono coinvolte nella discussione con i governi nazionali, ma hanno diritti di cittadinanza al limite del patto sociale prevalente.
Questi soggetti sono motivati a cercare nuove soluzioni, perché non godono di rendite di posizione. Sono già oggi costretti a cercare una via d’uscita alla crisi del welfare.
Una seconda linea di frattura è la crisi di identità e di ruolo degli agenti collettivi (burocrazia statale in primo luogo, ma anche dirigenza dei partiti politici – ridotta ormai allo spettro della leadership politica degli anni ’50 e ’60, e soprattutto delle forze sociali – sindacati dei lavoratori e delle grandi imprese nazionali).
L’organizzazione dello stato sociale (imprenditore) ha rafforzato il ruolo della tecnocrazia/burocrazia statale (collocata negli enti nazionali e locali e nei servizi collettivi). Negli anni del boom economico i dirigenti pubblici hanno avuto un ruolo produttivo, organizzando il lavoro “keynesiano” e l’investimento statale, mentre le forze sociali (sindacati e associazioni di categoria delle imprese) hanno provveduto a elaborare un sistema redistributivo adeguato, per via contrattuale e legislativa. Negli ultimi tempi (dal 1989 in poi – Seconda Repubblica in Italia) sono tuttavia diventati auto-referenziali e parassitari. Svolgono sempre più funzioni di esazione, per nome e per conto dei ceti privilegiati, e sempre meno funzioni utili e produttive per lo sviluppo.
Questo è il punto più critico. In tutti i paesi occidentali e soprattutto in Europa (dentro gli uffici della Commissione, all’OCSE o nei palazzi della BCE), i dirigenti delle organizzazioni burocratiche e riconosciute sono diventati il principale freno al cambiamento. Hanno in mano le leve del potere e bloccano ogni progetto di riforma. Le forze sociali che rappresentano hanno perso ruolo progressivo e si limitano a presidiare i propri interessi (entitlements), accettando addirittura regole di gestione del welfare che distinguono tra “entitled” e “escluded” (cittadini dotati di protezioni contrattuali e previdenziali diverse per lo stesso posto di lavoro o ruolo economico e sociale), contrari alle proprie regole statutarie. Usano la forza dello stato per difendere i propri privilegi.
Vedremo come riusciranno questi soggetti a gestire il New Green Deal comunitario!?
Poi ci sono gli “agenti finanziari” e gli imprenditori extra-territoriali. Soggetti “a-sociali” privati, che operano in rappresentanza del risparmio e guidano i processi di investimento “al posto degli stati” (keynesiani). E non a caso hanno un ruolo dominante negli incontri globali tipo Doha. Si sono rafforzati nel tempo e hanno assunto ruolo importante nella fase neo-liberale del sistema occidentale, a partire dai primi anni ‘90, proprio nel momento in cui la burocrazia ha sottratto efficienza allo stato keynesiano.
Non è un caso che Bill Gates si occupi oggi di ricerca sulle malattie infettive, al posto delle istituzioni nazionali e inter-nazionali come l’OMS, che non riescono a governare il sistema, oppresse come sono da burocrati senza competenza e responsabilità. E non è un caso che proprio questi ultimi si rivolgano sempre più spesso all’esterno dell’istituzione/associazione che rappresentano, all’iniziativa privata, anche per iniziative ordinarie che loro spettano per contratto (corrotti come sono dalla contro-riforma delle privatizzazioni, dall’idea che sia meglio appaltare all’esterno attività e funzioni che un tempo erano loro personale prerogativa). E non è un caso che in questo contesto siano i dirigenti di Blackrock direttamente a intervenire sull’agenda Green (Green New Deal), al posto dei burocrati e dei governi occidentali, che firmano trattati e fanno mille riunioni, ma non sono in grado di spendere le proprie risorse, restando perennemente impelagati nei processi di “governance” della PPAA, nella definizione di “bandi” e linee guida, nella continua, estenuante delega di responsabilità.
Nella fase di ascesa dello stato sociale, la tecnocrazia/burocrazia sapeva come usare le risorse finanziarie e le competenze tecnico-amministrative, per organizzare gli investimenti sulla casa, sulle infrastrutture e su alcuni grandi e moderni progetti industriali. Oggi questa tecnocrazia/burocrazia ha perso autonomia finanziaria e competenza operativa, non dispone più di capacità organizzative e di spesa diretta, utili a far funzionare lo stato di cui è, di fatto, “proprietaria”. Lo stato (nazionale e inter-nazionale) neo-liberale “esternalizza” ogni funzione, salvo l’indirizzo “estrattivo” delle risorse. Rifiuta ogni responsabilità produttiva, e preferisce “delegare” ai privati la gestione operativa dei progetti e delle risorse.
Autostrade in Italia docet!
Insomma, l’uscita dalla crisi sembra essere sempre poco plausibile a partire da questa élite e dalle istituzioni “sovraniste” e “nazionaliste” che ancora detengono il potere (almeno quello sancito dalle costituzioni vigenti), nel patto social-democratico prevalente.
Il problema urgente oggi, il che fare rivoluzionario del 2020, è come mobilitare i ceti sociali “in pericolo” contro questa élite incompetente e irresponsabile e come sostituire i ceti parassitari del welfare state con una leva di umanità fresca, allevata, se possibile, all’ideale di un nuovo mondo, più aperto e meno condizionato dai trattati, e nello stesso tempo più consapevole dei fallimenti dello stato sociale e del mercato.
Keynes ha fatto molto e rimane un riferimento ineludibile, ma deve essere superato da qualcun altro, inesorabilmente giovane e ambizioso, capace di elaborare un discorso sulla crisi innovativo, di proporre un paradigma migliore di quello dello stato sociale. Marx ha fatto e detto molto sui conflitti del capitalismo nazionale moderno ottocentesco, ma può e deve essere superato da un nuovo interprete delle fratture contemporanee.
Idealista che sappia scrivere un nuovo manifesto, del tipo “Migranti di tutto il mondo unitevi!”, cercasi urgentemente…

